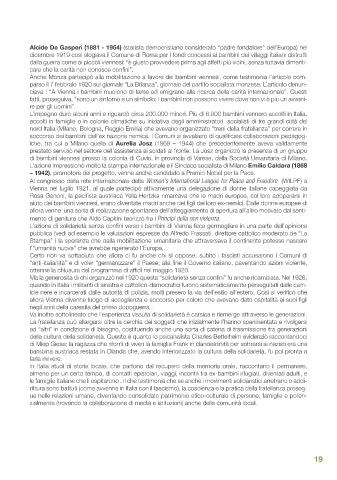Page 19 - catalogo definitivo
P. 19
Alcide De Gasperi (1881 - 1954) (statista democristiano considerato “padre fondatore” dell’Europa) nel
dicembre 1919 così elogiava il Comune di Roma per i fondi concessi ai bambini dei villaggi italiani distrutti
dalla guerra come ai piccoli viennesi: “è giusto provvedere prima agli affetti più vicini, senza tuttavia dimenti-
care che la carità non conosce confini”.
Anche Monza partecipò alla mobilitazione a favore dei bambini viennesi, come testimonia l’articolo com-
parso il 7 febbraio 1920 sul giornale “La Brianza”, giornale del partito socialista monzese. L’articolo denun-
ciava : “A Vienna i bambini muoiono di fame ed emigrano alla ricerca della carità internazionale”. Questi
fatti, proseguiva, “sono un sintomo e un simbolo: i bambini non possono vivere dove non vi è più un avveni-
re per gli uomini”.
L’impegno durò alcuni anni e riguardò circa 200.000 minori. Più di 6.000 bambini vennero accolti in Italia,
accolti in famiglie o in colonie climatiche su iniziativa degli amministratori socialisti di tre grandi città del
nord Italia (Milano, Bologna, Reggio Emilia) che avevano organizzato “treni della fratellanza” per correre in
soccorso dei bambini dell’ex nazione nemica. I Comuni si avvalsero di qualificate collaborazioni pedagog-
iche, tra cui a Milano quella di Aurelia Josz (1869 – 1944) che precedentemente aveva validamente
prestato servizio nel settore dell’assistenza ai soldati al fronte. La Josz organizzò la presenza di un gruppo
di bambini viennesi presso la colonia di Cuvio, in provincia di Varese, della Società Umanitaria di Milano.
L’azione impressionò molto la stampa internazionale e il Sindaco socialista di Milano Emilio Caldara (1868
– 1942), promotore del progetto, venne anche candidato a Premio Nobel per la Pace.
Al congresso della rete internazionale della Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) a
Vienna nel luglio 1921, al quale partecipò attivamente una delegazione di donne italiane capeggiata da
Rosa Genoni, la pacifista austriaca Yella Hertzka rimarcava che le madri europee, col loro adoperarsi in
aiuto dei bambini viennesi, erano diventate madri anche dei figli dei loro ex-nemici. Dalle donne europee di
allora venne una sorta di realizzazione spontanea dell’atteggiamento di apertura all’altro motivato dal senti-
mento di genitura che Aldo Capitini teorizzò fra i Principi della non violenza.
L’azione di solidarietà senza confini verso i bambini di Vienna fece germogliare in una parte dell’opinione
pubblica (vedi ad esempio le valutazioni espresse da Alfredo Frassati, direttore cattolico moderato de “La
Stampa” ) la speranza che dalla mobilitazione umanitaria che attraversava il continente potesse nascere
l’“umanità nuova” che avrebbe rigenerato l’Europa,.
Certo non va sottaciuto che allora ci fu anche chi si oppose: subito i fascisti accusarono i Comuni di
“anti-italianità” e di voler “germanizzare” il Paese; alla fine il Governo italiano, paventando azioni violente,
ottenne la chiusura del programma di affidi nel maggio 1920.
Ma la generosità di chi organizzò nel 1920 questa “solidarietà senza confini” fu anche ricambiata. Nel 1926,
quando in Italia i militanti di sinistra e cattolico-democratici furono sistematicamente perseguitati dalle cam-
icie nere e incarcerati dalle autorità di polizia, molti presero la via dell’esilio all’estero. Così si verificò che
allora Vienna divenne luogo di accoglienza e soccorso per coloro che avevano dato ospitalità ai suoi figli
negli anni della carestia del primo dopoguerra .
Va inoltre sottolineato che l’esperienza vissuta di solidarietà è carsica e riemerge attraverso le generazioni.
La fratellanza può allargarsi oltre la cerchia dei soggetti che inizialmente l’hanno sperimentata e rivolgersi
ad “altri” in condizione di bisogno, costituendo anche una sorta di catena di trasmissione tra generazioni
della cultura della solidarietà. Questo è quanto lo psicanalista Charles Bettelheim evidenziò raccontandoci
di Miep Giese; la ragazza che rifornì di viveri la famiglia Frank in clandestinità per sottrarsi ai nazisti era una
bambina austriaca restata in Olanda che, avendo interiorizzato la cultura della solidarietà, fu poi pronta a
farla rivivere.
In Italia studi di storia locale, che partono dal recupero della memoria orale, raccontano il permanere,
almeno per un certo tempo, di contatti epistolari, viaggi, incontri tra ex-bambini rifugiati, diventati adulti, e
le famiglie italiane che li ospitarono . Il che testimonia che se anche i movimenti solidaristici arretrano o addi-
rittura sono battuti (come avvenne in Italia con il fascismo), la coscienza e la pratica della fratellanza proseg-
ue nelle relazioni umane, diventando consolidato patrimonio etico-culturale di persone, famiglie e poten-
zialmente (trovando la collaborazione di media e istituzioni) anche delle comunità locali.
19